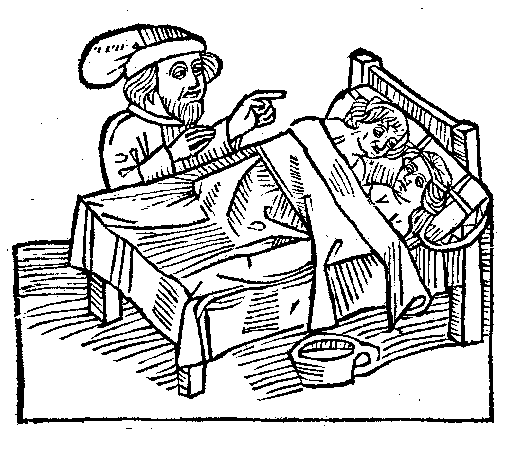Una vergognosa vessazione alla quale dovevano soggiacere le spose d’un tempo
LO “JUS PRIMAE NOCTIS”
Il “diritto della prima notte”, secondo il quale la novella sposa doveva “donarsi” al barone del paese, giuridicamente non è mai esistito, ma di fatto è stato largamente praticato, per alcuni secoli e sotto forme diverse, in ogni angolo d’Europa, Salento compreso.
di Emilio Rubino
Molto probabilmente questo strano e licenzioso diritto (?) nacque dall’errata interpretazione di un altro diritto, quello del Maritagium, che consisteva nel riscatto pagato al barone per compensare un antico diritto sugli sponsali. In realtà si trattava di una tassa che il padre della sposa doveva versare al signore per ottenere il permesso di dare una dote alla figlia. Un diritto, quindi, che gravava sui beni e non sulle persone.
Un altro elemento che contribuì a creare molta confusione fu il tributo che i novelli sposi erano tenuti a pagare alla Chiesa per poter consumare il matrimonio nella prima notte di nozze (da cui lo jus primae noctis), invece di trascorrerla castamente sulla scorta dell’esempio biblico di Tobia. Per evitare il precetto religioso, infatti, molte coppie (danarose) preferivano pagare al sacerdote una consistente somma di denaro in cambio di una speciale benedizione che le avrebbe affrancate dal grave… peccato.
Ben presto al sacerdote si affiancarono i vari feudatari che, sovvertendo unilateralmente ogni antica regola, pretesero di godere la primizia della verginità di tutte le spose (belle e piacenti) del loro territorio. Il futuro marito si trovava di fronte a due possibilità: quella di riscattare la propria moglie dagli abusi sessuali del signorotto, versandogli mezza marca d’argento, oppure quella di accettare, “capite demisso et orborto collo”, la vergognosa e intollerabile vessazione.
Davanti a tale diffusa prepotenza non mancarono casi di rivolta popolana contro i nobili, i quali riuscivano a sedare sul nascere ogni tentativo d’insurrezione, potendo contare su un nutrito e fedele manipolo di sgherri.
Vi era un altro più importante motivo che suggeriva ai villani di piegare la testa e subire ogni prevaricazione del loro dominus, dal quale dipendevano per ogni aspetto della vita quotidiana. Infatti, la casa in cui abitavano, o meglio la catapecchia, era di proprietà del signore, così come quasi tutte le attrezzature agricole. I sudditi dovevano lavorare per diverse ore al giorno sui terreni baronali in cambio di una modestissima paga e di misere granaglie, a stento sufficienti ad alimentare la numerosa famiglia. Inoltre il barone accordava loro il permesso di attingere acqua dalle cisterne padronali, di far legna nei boschi (il minimo indispensabile), di spigolare nei campi e di raccogliere gli ultimi grappoletti d’uva, le olive marce sfuggite alla raccolta o qualche frutto ormai sfatto. In pratica i villani erano legati mani e piedi per l’intera vita ai loro padroni, i quali, al sorgere della minima disubbidienza, sospendevano temporaneamente le concessioni o le revocavano sine die, nel caso di grave insubordinazione.
Anche i pochi “intellettuali” del tempo dovevano rigare dritti ed accettare supinamente ogni decisione che veniva dall’alto. Guai a dir male dei loro signori o a tramandare per iscritto episodi relativi alla pratica dello jus primae noctis o di altri soprusi: sarebbero stati cacciati immediatamente fuori dal contado.
Su tutti, ricordiamo il caso a noi vicino del neritino G. B. Tafuri, il quale, per paura di esporsi a gravi ritorsioni, tacque volutamente sugli inqualificabili crimini e prepotenze del suo signore. Infatti, egli non fa alcuna menzione nei suoi numerosi scritti dell’eccidio degli ecclesiastici neritini e dei tanti omicidi perpetrati dal sanguinario Guercio di Puglia nel 1647.
Pertanto le vaghe notizie sullo jus primae noctis e su altri misfatti ci sono pervenute non da documenti scritti, bensì da racconti popolari.
Anche i conti di Nardò pare praticassero un tal diritto e lo proverebbe il torrione angolare ad est del castello degli Acquaviva, da sempre denominato la “torre ti lu ‘nnamuratu”, nella quale, come narra un’antica leggenda, fu rinchiuso a marcire per il resto dei suoi giorni un giovane neritino, che, per non cedere la propria sposa al malevolo conte, si travestì da donna pugnalandolo mortalmente, allorquando il nobile tentava di metterli le mani addosso per abusarne.
Le modalità con cui i signorotti facevano conoscere alle novelle spose le loro perfide intenzioni sono avvolte in un alone di mistero, anche perché sono poche le testimonianze e gli scritti specifici. Ma è facile intuire la dinamica del misfatto. Qualche giorno prima del matrimonio alcuni emissari riferivano al padre della sposa o al futuro marito le pretese del signore. Tutto ciò scatenava l’immediata indignazione e il rifiuto categorico della donna. Probabilmente, dopo un’iniziale ma breve reazione, seguiva un sofferto conciliabolo tra i familiari (forse i maschi della casa), i quali, dopo aver soppesato attentamente la situazione, finivano con il convincere la donna ad accettare le avance del signore per salvare il futuro all’intera famiglia ed eventualmente godere di qualche ulteriore piccolo privilegio. A lei non rimaneva altro che rassegnarsi e concedere la sua verginità alle bramosie sessuali del signore padrone. Umiliata e violentata nel corpo e nell’anima, la donna portava dentro di sé il marchio indelebile della vergogna.
Un altro esempio eclatante è narrato da Antonio Amato, il quale, avvalendosi di alcune notizie tramandate da padre in figlio, in un suo libro[1] scrive che “il rituale prevedeva che il giorno del matrimonio il barone inviasse alla novella sposa una mela su cui era inciso un cerchio trafitto da una freccia, segno inequivocabile delle intenzioni dello spregevole individuo”, il quale – aggiungiamo noi – si prendeva anche il lusso di dileggiare ripetutamente il nome della donna davanti a tutti, familiari compresi.
Si racconta, inoltre, come a Novoli il famigerato barone Mattei facesse uso, vantandosene, di questa infame pratica. All’indomani di ogni incontro amoroso avuto con la vittima di turno, il malvagio signorotto faceva sventolare sulla torre del suo castello di Pozzo Nuovo una bandiera bianca, nel caso avesse trovato ancora integra la sua vittima, una bandiera rossa se invece la poveretta fosse stata trovata già deflorata. Gli eccessi di questo turpe barone finirono, però, con il provocare una cruenta sollevazione popolare, nel corso della quale il feudatario rimase ucciso e il suo malfamato castello raso completamente al suolo.
Coll’avvicinarsi dei tempi moderni le masse popolari cominciarono ad acquistare una nuova mentalità e maggiore dignità, cosicché lo jus primae noctis iniziò a vacillare, per poi scomparire definitivamente. Ma i feudatari, non potendo più usufruire dei piaceri carnali delle novelle spose, trasformarono l’antica e perversa pratica in una tassa speciale sul matrimonio, chiamata “diritto della cunnatica” o anche “ragione delle femmine quando si maritano”.
A tale tassa fa esplicito riferimento un ignoto scrittore in una sua lettera[2], datata 22 aprile 1737 e conservata nell’Archivio di Stato di Napoli, il quale, parlando degli abusi dei baroni di Veglie, precisa che “ogni sabato debba il vassallo coniugato contribuire al barone un determinato pagamento per essersi giaciuto in letto con la propria moglie in quella settimana, il quale pagamento, attrassandosi (attardandosi) di un sabato, nell’altro se ne deve poi sodisfare la multa di maggior somma”.
Tale diritto era valutato in quattro carlini all’anno. Il barone di Torrepaduli, in quel di Ruffano, ha continuato ad esigere la tassa sino a tutto il 1750[3].
Poi, grazie all’abolizione del sistema feudale (12 agosto 1806) fu spazzata definitivamente l’ignominiosa impalcatura su cui prosperavano prevaricazioni, turpitudini, sofferenze ma anche atti di vera barbarie da parte dei feudatari.
Oggi, meno male, si respira un’aria nuova, diversa. La donna ha finalmente rotto le catene della sottomissione al “fiero maschio”, ha conquistato una posizione sociale gratificante e non più umiliante, svolge compiti e mansioni di prim’ordine. Ma non è tutto. La donna deve ancora affrancarsi da se stessa, cioè da quell’antico retaggio che si porta ancora dentro e che le ostacola il normale processo evolutivo della propria personalità. Purtroppo, in questi ultimi cinquant’anni, si è essenzialmente impegnata ad apparire donna (è sin troppo facile), ma poco ha fatto per diventare donna (è molto difficile).
Gli uomini (quelli veri) non hanno bisogno di donne di facciata, di figure imbellettate e profumate, frivole e fascinose, bensì di donne colte, intraprendenti, vivaci, libere da ogni condizionamento sociale e, tutt’al più, un po’… misteriose e seducenti.
[1] Il libro in questione è “C’era una volta… Castrignano de’ Greci”.
[2] …un ignoto scrittore in una sua lettera – A tale prezioso documento fa riferimento l’Almanacco Salentino – edizione 1968-69 (pag. 182).
[3] Il barone di Torrepaduli… – Cfr. D. Winspeare in Storia degli abusi feudali, pag. 211 – Forni Editore, Napoli, 1883